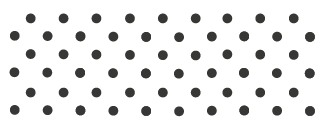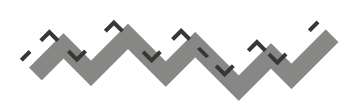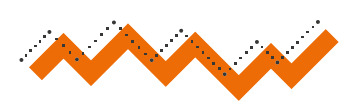La sala accoglienza è un bar del Pacifico anni ’30, con tutti gli arredi originali. Dalle grandi finestre, s’intravede il mare. Ma, soprattutto, Genova. Distesa verso le onde e arrampicata lungo i primi crinali dei monti. Sono nella sede della Velier, azienda riferimento nella selezione e commercio di vini e liquori. Il meglio del mercato mondiale passa di qui. E molto è merito di quest’uomo abbronzato che ho davanti, in jeans chiari, all star color fumo, girocollo blu scuro. È Gian Luca Gargano: globetrotter, fotografo, esperto di rum e distillati, nipote di vignaiolo, teorico dei vini naturali.
È stato lui, nel 2001 – quando di vini bio non si parlava ancora – a lanciare i vini Triple A. Tre A che stanno per Agricoltori, Artigiani, Artisti. Perché soltanto chi coltiva il vigneto può instaurare un rapporto corretto tra uomo e vite, nel segno dell’artigianalità e di interventi agronomici naturali. Con un pizzico di sensibilità artistica. Ne ha fatto un movimento riconosciuto in tutto il mondo, coeso attorno a un decalogo preciso e rigido, che traccia un lavoro agricolo e contadino nel rispetto dei cicli della natura e di ogni singolo terroir.
Uno che è partito da zero. Poco più che ragazzo, nel 1983, ho preso la Velier, che era una piccola azienda. Quando mi presentavo agli appuntamenti di lavoro, coi capelli lunghi, guardavano alle mie spalle: pensavano fossi l’autista del titolare. Mi trattavano come se avessi ancora il latte sulle labbra. Ero giovane, in un’epoca in cui i giovani erano poco considerati. Da allora, tutte le scelte della Velier hanno trasudato coerenza: o il massimo della qualità o prodotti innovativi.
Sono riuscito a realizzare un sogno: un’azienda che detenesse le mie linee guida. Al pil prediligo il fil, ovvero la felicità interna lorda. La prima regola è dire sempre sì, finché non è proprio impossibile dire no: a tutta la catena, dagli agenti ai clienti. Non pensare al profitto prima del prodotto. E rispettare i rapporti umani, perché una distribuzione di precisione ha bisogno di persone, non di una filiera più corta. Il nostro è il mestiere dei vecchi mercanti: scoprire qualcosa che ci dà piacere, per proporlo ad altri. Qualcosa d’avanguardia, autentico, o eccezionale.
Io divido in before internet e after internet. Ho cominciato a lavorare a 18 anni, a 38 avevo già girato il mondo: quando si è affermato internet, avevo il vantaggio d’essere in anticipo. Oggi chiunque può ricercare sul web, pur senza sapere l’inglese. C’è il traduttore automatico, anche se magari traduce vagito per vagina. Ma per essere avanti, bisogna essere oltre internet. Occorre portare il proprio nomadismo esplorativo oltre i confini, in quella zona che i romani chiamavano hic sunt leones. L’ignoto, insomma. Ma è un’area che si sta restringendo sempre di più.
Ad aiutarmi, per fortuna, ci sono quelli che definisco ragazzi post Chernobyl: io assumo solo chi non sapeva leggere e scrivere nel 1986 o ancor meglio nati dopo il 1986.
Partiamo da un postulato: non tutti i vini naturali sono buoni, ma nessun vino non naturale è buono.
Le triple A sono nate da un mio protocollo personale, perché dopo 20 anni mi sono accorto di non riuscire più a degustare un vino. Non capivo più un cazzo di vino. Serge Hochar – un uomo incredibile, un vignaiolo del Libano produttore di vini fantastici – mi ha aperto gli occhi: io, considerato esperto di vino, con un nonno vignaiolo, nato in mezzo ai vigneti, erano anni che non mettevo più piede in vigna. Mi sono riavvicinato alla terra, e ho compreso che era impossibile trovare un’espressione autentica e originale in un vino diventato prodotto industriale. Un vino per essere vino deve essere fatto con il suo sperma, ossia i suoi lieviti, e con meno trucchi possibili. Poi in questo paradigma c’è la Romanée-Conti e il vino che facciamo io e te e che fa cagare.
Queste riflessioni le ho partorite tra il 1998 e il 2001. Il 7 luglio 2001 è uscito il protocollo dei vini Triple A e contemporaneamente ho eliminato tutti i vini che fino ad allora erano nel listino Velier.
Il mio protocollo è semplicemente la frontiera che divide due insiemi. Quello che io chiamo vino è il prodotto di una selezione massale, di un’agricoltura pulita, di una raccolta fisiologica delle uve, dell’utilizzo dei propri lieviti, senza cambiare parametri chimico fisici in cantina, utilizzando meno solforosa possibile in tutti i processi.
Bisogna capire cos’è il palato. Gli alimenti oggi sono analizzati dal punto di vista chimico, fisico e microbiologico, e non dal punto di vista dell’energia e dell’informazione. L’energia è informazione. La cristallizzazione di una goccia di latte materno su un materiale conducente, ti fa un disegno straordinario. Una goccia di latte artificiale, che ha le stesse caratteristiche chimico-fisiche, non ha alcuna energia. Ciò che mangiamo è nutrimento per il sistema neurovegetativo. Noi siamo ciò che mangiamo, ed è proprio così, ma non a livello fisico: a livello di coscienza.
L’approccio degustativo odierno è basato su un errore clamoroso. È un approccio anglosassone: partire da un particolare per risalire al generale. È come fare l’identikit dell’assassino partendo da un’unghia. Non si può partire da un dettaglio, da un profumo di pomodoro maturo per capire cos’è un vino. Un vino è la materializzazione di un terroir, di un luogo, di un anno: è un insieme del tutto.
Più uno è disarmato, più è pronto a ricevere. Per questo io adotto il test GLG: prendo un bicchiere, verso il vino e bevo. È il mio metodo per oltrepassare il palato culturale. Bevo, e immediatamente capisco se è buono o meno, se mi ha dato un brividino o un uppercut. Solo in seguito lo degusto tecnicamente.
La materia prima è fondamentale. Se distilli una merda avrai una merda al cubo, se distilli un angelo avrai un arcangelo. Ora c’è questo surrealismo per cui devo spiegarti che da una uva sana, maturata perfettamente, che ha ricevuto dalla terra e dalla luce determinate caratteristiche, può uscire un buon vino.
Nel mondo del vino, Serge Hochar. Per i sigari, Don Alejandro Robaina. Nel mondo della distillazione, Gianni Vittorio Capovilla. Aggiungo l’enologo Giorgio Grai, che ancora oggi, a 80 e passa anni, ha una lucidità e conoscenza incredibile.
Haiti. Lo consiglio a tutti. Gli schiavi non hanno il diritto di ribellarsi e ancor meno di vincere. Gli haitiani sono stati gli unici schiavi al mondo che nel 1804 si sono ribellati, hanno vinto, hanno fatto un culo così ai francesi e hanno creato la prima repubblica negra indipendente, e quindi hanno ricevuto il cartellino rosso per l’eternità. L’hanno tenuto fuori dal mondo, è stato il paese più povero e sfigato. Oggi è una chance enorme: ha 1500 chilometri di spiaggia dei Caraibi completamente deserti, hanno la canna da zucchero, una ricchezza gastronomica incredibile. Molte zone sono ferme al’Ottocento. In tutti i Caraibi ci sono solamente 49 distillerie fumanti, nella sola Haiti gli alambicchi fumanti sono 532, tutti moonshine. Trovo che Haiti sia un posto unico, dove hai lo stupore dell’originalità: è una straordinaria macchina del tempo.
Per arrivare da lui devi essere davvero Indiana Jones. Sta a 42 chilometri dall’ultimo tratto di strada asfaltata, e a percorrerli in auto ci si sta più di un maratoneta. All’arrivo, si apre una valle verso il mare, indescrivibile. Magari vedi dall’alto un veliero a tre alberi che trasporta carbone, e pensi che sia un film. Invece è tutto vero. Non hanno mai visto una bottiglia, producono per il paese, mettono in bidoni da 55 galloni e portano al droghiere del paese, che vende corde, aglio, preservativi. E straordinari Clairin.
Ho viaggiato ovunque, ma non mi sono mai sentito davvero a rischio. In Mongolia nel 1992, ho passato brutti giorni. C’era la peste bubbonica, siamo stati inseguiti, ho subito l’ammutinamento dei sette mongoli armati che mi accompagnavano.
Nel 1990, mi sono perso nelle Ande, sopra i 4000 metri, senza alcun punto di riferimento. Mi sono trovato con metà serbatoio, a 4300 metri, su una quebrada, uno strapiombo di 1000 metri di dislivello con neve ghiacciata, e un centimetro da un lato per passare. Avevo con me le bambine piccole, mi sono messo quasi a piangere.
Oggi tutti mi chiedono: ma non è pericoloso andare in Guinea Bissau? Vuol dire che negli ultimi venti anni la percezione del pericolo è cresciuta moltissimo. La percezione, però, non il pericolo reale. D’altra parte, viviamo nell’epoca in cui per andare al ristorante fuori città dobbiamo prima consultare le previsioni del meteo.
Domanda molto difficile. Io penso che l’incrocio tra i geni arabi e mediterranei produca probabilmente le donne più belle del mondo, non solo fisicamente. Ma dal punto di vista atletico, superiorità nera assoluta: Africa e Caraibi.
Più che un prodotto, si cercherà un metodo. Si affermeranno i distillati artigianali, a scapito degli industriali. Quei distillati che provengono da un savoir fare artigianale che conosciamo da 600 anni: quello delle doppie distillazioni in alambicchi di rame. E si sentirà parlare sempre più di single: al pari dei single malt per il whisky, ci saranno single rum, single Calvados, eccetera.
La mia prossima scommessa sono proprio i single rum, che riportano in etichetta il disegno dell’alambicco – unico e inimitabile – in cui sono stati distillati.
Più che il terroir, deve crescere il testulin di chi fa i vini. Penso però che il Brda, il collio sloveno potrà migliorare moltissimo le sue performance. Anche la Georgia, la madre di tutti i vini. E la Moldavia ha un grande potenziale.
Penso che Cristoforo Colombo si rivolti nella tomba tutti i giorni, perché sono rimasti pochi esploratori e pochi imprenditori. D’altra parte ritengo, senza sciovinismo, che Genova sia una delle più belle città del mondo. Il problema di Genova sono i genovesi. Manca l’impulso del commercio, della scoperta, del business. Genova è vittima dello snobismo di una borghesia aristocratica che si è incrociata tra se stessa e non ha più nessuna energia.
Nessuno mi ha mai chiesto se sono veramente felice.
Probabilmente perché è palese, mr. Velier.